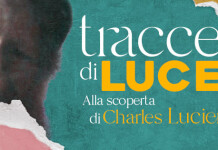A Marrakesh, in Marocco, 164 Paesi dell’Onu hanno adottato il Global Compact. Criticato dai movimenti anti migranti e dai nazionalisti, il patto ha come principale obiettivo quello di garantire una migrazione sicura, ordinata e regolare. Nel mondo sono circa 260 milioni le persone migranti, circa il 3,4% della popolazione mondiale. Un fenomeno globale che non può essere gestito individualmente dai singoli Paesi.
Eppure i 23 punti non vincolanti del Global compact non piacciono agli Stati Uniti, che hanno definito l’accordo un “tentativo delle Nazioni Unite di far avanzare una governance globale a spese della sovranità degli stati”, ottenendo il sostegno di altri paesi: Australia, Repubblica Dominicana, Lettonia e quelli gruppo di Visegrad. La rappresentante delle migrazioni Onu, Luoise Abour, ha dichiarato: “È sorprendente che ci sia tanta disinformazione sul compact e su quello che stabilisce veramente. Non dà nessuna imposizione agli stati”. Tante sono le posizioni scettiche: Italia, Bulgaria, Estonia, Israele, Slovenia e Svizzera sottoporranno infatti la questione dei migranti a un dibattito parlamentare. In Belgio l’approvazione del Global compact for Migration è stata addirittura la causa della rottura della coalizione di governo.
Intanto le migrazioni continuano, e non mancano le tragedie. Il 4 dicembre 14 persone sono morte al largo della Libia, dopo giorni di sofferenza inflitta dalla fame e dalla sete. Il barcone di legno con 25 migranti di diverse nazionalità africane era salpato da Sabrata, a una distanza di circa 70 chilometri in linea d’aria da Tripoli. Un ennesimo viaggio della disperazione, che conferma il fallimento delle politiche di chiusura dei confini.
Quello dell’immigrazione è un evento epocale, complesso e non riguarda soltanto le persone che si spostano per ragioni economiche, sociali e politiche in altri stati. Sono in molti casi i fenomeni come la siccità, la desertificazione e il fallimento dei raccolti che costringono milioni di persone a cercare nuovi luoghi per poter vivere. Il rapporto “Groundswell- Preparing for internal climate migration” ha previsto che potrebbero essere 140 milioni i migranti ambientali costretti ad abbandonare le proprie case a causa di eventi climatici estremi entro il 2050.
Tre macro-aree sono a rischio: Africa subsahariana, l’Asia meridionale e l’America Latina. Secondo i dati della organizzazione non governativa Oxfam, tra il 2008 e il 2016, ogni anno 21,8 milioni di persone sono fuggite dal proprio stato o dal proprio continente in seguito ai disastri ambientali. Quando non è possibile fuggire, molte popolazioni devono affrontare il problema della scarsità delle risorse, che sono alla base di conflitti violenti e sconvolgimenti comunitari. Un esempio è la guerra nel Darfur, scatenata dalle dispute per le terre fertili e l’acqua dolce. Mentre in Siria i principali spostamenti dalle aree rurali verso le città sono stati determinati dalla siccità. E i cambiamenti climatici potrebbero produrre ulteriori spargimenti di sangue nei prossimi anni nelle zone più povere del mondo, dove ogni 15 secondi un bambino muore per malattie a causa del consumo di acqua non potabile.
La tutela delle risorse idriche e il cambiamento climatico sono pertanto questioni fortemente connesse, che devono essere affrontate tenendo conto dei rispettivi legami e della loro influenza sull’ambiente e sulla vita delle persone. All’accelerazione dei cambiamenti climatici è direttamente legata un’ulteriore diminuzione della possibilità di accesso alle risorse idriche mondiali. Un problema che nel 2025 coinvolgerà 3 miliardi di persone. Le zone maggiormente colpite sono Cina, India e aree subsahariane, mediorientali e nordafricane. Questi fattori, assieme all’avanzare della desertificazione e alla perdita dei mezzi di sussistenza per milioni di persone, rendono la crisi idrica mondiale una delle emergenze ambientali più gravi tra quelle in corso.